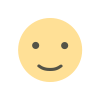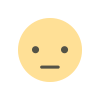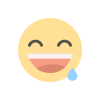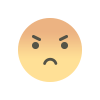Vita mitocondriale di una donna moderna
Silvia Belcastro

D’ora in avanti non mangerai quasi più niente e la tua vita cambierà”, disse il medico. Segaligno, emanava irritazione e stanchezza. Gli occhi azzurri cerchiati da occhiali arancione non si addicevano a un genio incattivito dalla stupidità umana. Mi accompagnò all’uscita. “Non sei pazza”, disse. Si mise le mani intorno al viso, imitando i paraocchi dei cavalli: “Sono quasi tutti così, i medici. Vai via. In montagna, al mare. In un luogo più pulito”. Mi strinse la mano nelle sue e mi concesse il primo sorriso, come un segreto tutto per noi: “Allora, cosa farai di questa vita che ho salvato?” Lo soprannominai “Il Luminoso”. Dopo vent’anni di dolore fisico e psicologico, non fu difficile seguire le sue indicazioni, anche se sarebbero state crudeli persino per un corso di sopravvivenza in ambienti estremi. I miei pasti si trasformarono in quadri zen composti di pochi colori: riso, pollo, insalata, zucchini e mela. Dopo alcuni mesi comparvero le prime crisi: il cervello rifiutava di mettere in bocca il cucchiaio. Inventai inganni per bambini: frullai la mela per farne un sorbetto e tagliai le zucchine per riempirle di pollo. Poi le crisi cessarono e il cibo divenne soltanto questo: cibo. Cominciai ad aggirarmi per il mondo come un panda in un supermercato. Perché tutto era “tossico” per me? Cos’era successo al mio corpo? Perché non ero più in grado di distinguere il cibo da un aggressore contro cui aizzare un esercito di mediatori allergici? La sera, mescolando il riso, mi veniva in mente Fuga di morte, imparata ai tempi della scuola. La ripetevo a memoria, cercando l’intonazione perfetta: “Nero latte dell’alba lo beviamo la sera / lo beviamo a mezzogiorno e al mattino lo beviamo di notte”. Ogni volta che mi sembrava di essere sulla strada giusta per risolvere il problema, qualcosa nel mio corpo non funzionava. I medici mi chiedevano 150 euro per visite inutili. Mi ritrovai a studiare biochimica, immunologia e neurologia. “Nero latte dell’alba ti beviamo la notte / ti beviamo al mattino e a mezzogiorno ti beviamo la sera”. Un altro cucchiaio di riso, un’altra zucchina, un’altra giornata, altri 500€ di farmaci. “Beviamo e beviamo / Nella casa abita un uomo che gioca con i serpenti che scrive”…
Ad un certo punto ho capito la verità, ma ho impiegato un anno a convincere il Luminoso a scriverla. La verità è a volte troppo complessa per stare sotto una sola etichetta. Le diagnosi sono controverse, multidisciplinari, legalmente scomode o semplicemente non riconosciute dallo Stato. Alcune cose però sono chiare. Innanzi tutto, da decenni a questa parte una schiera di neurologi, immunologi, tossicologi, internisti, psichiatri, psicologi e biochimici ha dimostrato che le sostanze chimiche sintetizzate dall’uomo sono un fattore determinante nell’impennata di numerose malattie e disturbi psicologici: malattie autoimmuni, neurologiche, neuropsichiatriche, allergie, intolleranze ai cibi e malattie da ipersensibilità. A volte i diversi aspetti – virale, batterico, chimico e psicologico – possono presentarsi assieme ed è impossibile districarli. Tuttavia, la medicina ufficiale non è ancora pronta per un cambio di paradigma e la società sta condannando sé stessa alla malattia e alla morte. Prima di conoscere il Luminoso, avevo passato dieci anni tra il letto e il divano. All’epoca impiegavo ore ad alzarmi dal letto, le braccia e il collo come metallo incandescente. Mi svegliavo la mattina con le labbra gonfie e il naso chiuso, senza riuscire a respirare. Dopo un paio d’ore dovevo già sdraiarmi, spossata e con la pelle bollente. Non tolleravo il cibo e fui operata tre volte per occlusione intestinale: a 21, a 28 e a 30 anni. Al primo affaticamento perdevo i sensi o vedevo doppio. Dormivo sempre. I profumi e il fumo delle automobili, che fin da bambina mi avevano causato malessere, mi colpivano come un’offesa: di colpo sentivo svanire le forze, lo sguardo si faceva fisso, avevo bisogno di zuccheri e faticavo a respirare. A venticinque anni il dolore attraversava il mio corpo come lame d’acciaio. Pensare, ricordare e decidere cose semplici era difficile. Avevo la sensazione che la mia mente fosse sovraccarica. Avevo attacchi di ansia e panico. Muovermi era quasi impossibile, “come se” le mie cellule non avessero riserve energetiche e non riuscissero a respirare. A volte dimenticavo le parole o le scambiavo fra loro: dicevo “tartaruga” invece di “padella” e “albero” al posto di “autobus”. Mensilmente percepivo i miei ormoni salire e scendere modificando il mio umore. I miei sogni notturni erano abitati da miasmi tossici e la mattina boccheggiavo, la mente avvelenata da un cocktail chimico mescolato ad angoscia nauseante. Quando la temperatura nella stanza era troppo alta o non dormivo abbastanza, sentivo che le sostanze chimiche nel mio cervello si alteravano, distorcendo i miei sogni e impedendomi di svegliarmi. Correvo fuori di casa per respirare aria fresca, svegliare il cervello e scollarmi di dosso quel senso di vomito misto a depressione. Avevo la sensazione di vivere la vita di qualcun altro, “come se” la mia identità fosse stata rubata. Non avevo ancora letto libri sul cervello o studi sugli effetti delle sostanze chimiche sul corpo umano, per cui non capivo come fosse possibile essere depressi, ottusi, avvolti in una nebbia mentale (si chiama proprio così) e al tempo stesso sapere di essere un’altra persona. Non sapevo dove avessero origine i pensieri e le emozioni. Vivevo semplicemente nel dolore, come se fosse normale. Eppure la vedevo, questa altra persona in un universo parallelo e luminoso, quella che da qualche parte ero ancora e che sarei stata: era sempre un passo davanti a me, al di là di un velo. Sembra impossibile che per decenni i medici non abbiano dato peso ai miei sintomi, ma in verità lo vedo fare spesso con le donne. Ho iniziato a nascondere la mia seconda vita dietro la battuta facile e un’intelligenza vivace. Di qua dal velo, fingevo di esistere. Facevo lavoretti che mi consentissero di credere che potevo fare qualcosa. Ero un’attrice di teatro, un’insegnante privata, una pianista. Dipingevo, cercando di mettere al sicuro quel mondo luminoso. Mi sembrava però di non trovare spazio nella società in cui vivevo: non potevo lavorare alle condizioni richieste, perché erano ostili al mio organismo. Quel diritto e dovere morale, sancito dalla Costituzione Italiana, di fiorire e rendere alla comunità un contributo secondo il mio talento e le mie possibilità, mi era negato. Ero moribonda e per qualche ragione non vista o umiliata dalla medicina. La mia mente e il mio corpo ormai avevano un contatto con la persona di là dal velo solo dopo le quattro del pomeriggio e dopo alte dosi di antidolorifici. La maggior parte delle persone alzava le sopracciglia e i medici mi liquidavano coi soliti “problemi psicologici”. Le mie analisi non erano alterate e la ragione era semplice: erano le analisi sbagliate. La prima volta che ho incontrato Flora, io avevo 35 anni e lei 55. Non sapevo come comportarmi. Nonostante fossi una veterana della sofferenza, ero una novizia della consapevolezza. Dopo tanti anni di dolore, avevo appena iniziato a imparare il lessico della prigionia e i trucchi per sopravvivere. Come chi entra in campo di concentramento, avevo appena ricevuto una nuova identità e un numero 2Q24. Stavo imparando chi ero e chi erano le mie compagne. Con Flora, tutto doveva essere perfetto. La punizione per i miei errori sarebbe stata la sua tortura fisica e psicologica, così prima di incontrarla ho scelto dei vestiti vecchi e li ho lavati tre volte con acqua, sale e bicarbonato. Li ho stesi nel vano caldaia perché non prendessero odore, li ho avvolti nella carta velina e li ho messi in una busta di plastica. Ho lavato le scarpe e il giorno dell’incontro le ho messe in freezer per attenuarne l’odore di gomma e formaldeide. Mi sono vestita solo prima di uscire, dopo aver fatto una doccia sfregandomi la pelle con il bicarbonato. Ho indossato una tuta e una giacca di pile, poi un’altra giacca. Faceva freddo e le scarpe ghiacciate erano una tortura. Mi sono accorta tardi dell’errore: avevo chiuso i vestiti nella busta di plastica quando non erano ancora asciutti, col risultato che ora odoravano di palude. La stagione era umida e puzzolente, e io vivevo ancora in un ambiente non “bonificato”. Nel lessico del mondo separato in cui ormai vivevo – che io chiamavo il Lager – significava che i miei familiari utilizzavano ancora insetticidi e prodotti profumati. Indossare altri vestiti avrebbe solo peggiorato le cose. Nel tratto che ho percorso in bicicletta ho sentito l’aria appiccicarsi alla giacca in minuscole goccioline, insieme ai resti dell’attività umana e vegetale: polveri dei camini, fumo di automobili, frammenti di erba tagliata e profumi economici. Pensai a Marina, che mi aveva istruito su come comportarmi. L’avevo conosciuta su Facebook e non avevo mai visto neanche lei. Facebook, che aveva fornito gli strumenti a una nuova dittatura globale, aveva fornito a noi la possibilità di costruire una resistenza. Flora era già fuori ad aspettarmi, come una bambina impaziente. Indossava occhiali da sole, sciarpa e berretto. La sua figura slanciata era avvolta in strati di abiti vecchi, ma anche così coperta era evidente che non riusciva a mangiare abbastanza. I cibi le causavano ulcere in bocca, dolori, svenimenti e crisi allergiche. Chiunque l’avrebbe associata a quelle fotografie di Auschwitz che si vedono sui libri di scuola: “Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, considerate se”. Eppure, qualcosa in lei stonava: da quelle ossa ricoperte di pelle traboccava un’intelligenza così vivace che mi chiesi come potessero contenerla senza andare in frantumi. Come il motore di una Ferrari su una Cinquecento vecchio modello. Facemmo una passeggiata. L’ora d’aria: un percorso preciso attraverso pochi lotti di terra non ancora edificati. Flora non poteva allontanarsi: le sue cellule non erano più in grado di sostenere l’inquinamento nell’aria, nei cibi, negli abiti e nei cosmetici delle persone. Il suo corpo era andato in TILT. TILT è un termine tecnico, un acronimo in lingua inglese che significa “perdita di tolleranza indotta da sostanze chimiche”. In poche parole, le capacità detossificanti dell’organismo erano state alterate da numerosi stress e intossicazioni chimiche. Il suo sistema nervoso reagiva ora come un diapason alla minima vibrazione, un po’ come se fosse stata seduta per anni su una sedia elettrica. Qualunque residuo chimico sulla mia pelle, sui miei capelli o sui miei abiti avrebbe attivato in un attimo lo scanner ipersensibile dei suoi recettori. Avrebbe percepito quelle molecole come una lepre assediata odora il bosco in fiamme. L’odore sarebbe esploso nel suo naso e nella sua gola causandole dolore fisico, difficoltà respiratorie e disturbi neurologici. Da molti anni non poteva frequentare luoghi pubblici né girare per le strade. Non poteva mangiare, ma con la mia sola presenza l’avrei costretta a ingoiare il sapore delle discariche umane. I vestiti che indossava erano vecchi perché quelli nuovi le scatenavano crisi allergiche: troppo pieni dei residui di lavorazione. Non ho potuto fare a meno di pensare che uno degli aspetti principali delle dittature è la perdita dell’identità. Nel Lager del neoliberismo e dell’industria chimica, stavo vedendo esattamente questo: spettri di donne si aggiravano tra le rovine. Barcollanti, intossicate e dimentiche di sé stesse. Organismi resi disfunzionali come erbaccia trattata col glifosato. Arrivate al parco giochi, Flora mi mostrò le strisce arancio sull’erba ai bordi del marciapiede. “Eccolo qui”, disse. Due giorni prima avevamo mandato l’ennesima lettera al Comune per protestare contro l’utilizzo sconsiderato di insetticidi. I bambini giocavano a pochi metri da noi in una nuvola di profumo chimico: vestitini lavati con ammorbidenti che i nostri recettori percepivano a centinaia di metri di distanza. Le molecole passavano la barriera protettiva del nostro cervello senza chiedere il permesso, distruggendo le scorte di energia nei mitocondri delle nostre cellule. Sentii il dolore attraversare il lato del mio viso rivolto al parco e una lama conficcarsi al centro della mano. La mia mente divenne vuota, tuttavia vagamente ansiosa e arrabbiata per l’improvvisa attivazione della mia amigdala. Mi chiesi cosa stesse provando Flora, che non poteva placare i sintomi con i farmaci. Sorrideva pacatamente, come al solito. “Devo mostrarti la mia Lobivia. Ha fiorito, sai?” È passato tanto tempo da quel primo incontro. Oggi sono una veterana non solo del dolore fisico e psicologico, ma anche della sua nomenclatura e dell’identità che il Lager ci ha appiccicato addosso. Una parte della mia storia appartiene ai numeri marchiati a fuoco sul mio DNA. Sono 2Q24, che è l’acronimo della mia qualità post-umana. Tecnicamente, si tratta di un “addotto” sul DNA. Ho beta-naftolo sul cromosoma 2, segmento Q24. Questa sostanza chimica sintetica – un derivato del benzene – inibisce un gene fondamentale nella metabolizzazione dei grassi e nella produzione di ATP (leggi: “energia”) per la totalità delle mie cellule e tutti i miei organi vitali. Non so dirvi se è arrivato lì mentre ero nel grembo di mia madre o in qualche momento della mia vita. Considerando la quantità di sostanze tossiche a cui siamo esposti in casa e fuori (attraverso il cibo, la plastica, i medicinali, i profumi, i pesticidi…) e il ruolo di virus, batteri e stress psicologico nella distruzione del nostro cervello, del nostro sistema immunitario e del nostro genoma, è una domanda irrilevante. Essenzialmente, gli addotti sul DNA sono solo una piccola parte del quadro di come il lato oscuro della modernità Influisce sulla nostra salute. Non sono neanche necessariamente permanenti. È così difficile evitare l’eredità di un genoma indebolito o l’esposizione quotidiana a potenti sostanze tossiche, che avere una predisposizione genetica o addotti sul DNA sta diventando irrilevante. Oggi conosco le regole per sopravvivere alla prigionia e riconosco le reclute a chilometri di distanza. Spesso cerco di salvarle, così come altre donne hanno cercato di salvare me. Si, perché siamo quasi tutte donne, la maggior parte inconsapevoli. Abbiamo dolore e intolleranze alimentari. Siamo sensibili alle sostanze chimiche, ai profumi, ai metalli, alle plastiche, ai farmaci e agli odori. Abbiamo gli ormoni sballati, i mitocondri danneggiati e il cortisone nella tasca dei jeans. I bambini sono già tanti e gli uomini stanno cominciando ad arrivare. La cosa più difficile è stato accettare che non siamo più un’eccezione. Siamo ovunque. Vedo giovani donne malate su Instagram, Facebook e Twitter. C’è un’estetica affettata che ricorre in molte immagini, mescolata a citazioni che dovrebbero ispirare e a pillole di pensiero positivo. Sembra l’unico modo in cui ci è permesso entrare in società, come se i sopravvissuti fossero presentabili soltanto se ingentiliti. A volte portiamo una maschera bianca, a volte restiamo in casa a mangiare riso e zucchine, abituate a sentirci chiamare pazze. Quando possibile, ci imbottiamo di antidolorifici e antistaminici e tentiamo di restare nella società e trovare un lavoro. Siamo le madri malate di un futuro malato, corpi modificati dal neoliberismo. Stiamo comparendo su tutti i giornali: Sensibilità Chimica Multipla, Fibromialgia, Stanchezza Cronica, Malattie Autoimmuni. Stiamo straripando come un’onda di formiche sballate, zombie che ricadono fuori dai fogli bagnando l’inchiostro, finché al mondo non si leggerà più nulla se non la nostra storia. Siamo i morti che camminano, i morti che cadono, i bambini che piangono. Siamo talmente tante che non si fa in tempo a spazzarci via.
Silvia Belcastro